Organic music & organic wine: Don Cherry e Les Gains de Maligné
“We can be in tune with time, we can be a slave to time or we can be in total aspiration trying to catch time.
There must be a fourth way: to flow with time. This is the organic way, the way of the organic society: to flow with time”
(Don Cherry – “Relativity Suite”)
<<Questo non è un disco jazz. Questa è la musica di un rituale. Ogni somiglianza con il jazz è puramente casuale e incidentale. Questo è il suono dell’utopia, dell’uguaglianza, del sogno egalitario universale, della terra, dell’acqua e delle forze vitali nelle loro varie forme. (…) È il suono del respiro, della comunità, della socialità e, fondamentalmente, del popolo. Un suono nel quale ci si preoccupa poco di fedeltà audio o di virtuosismo. Tutto ciò che importa è il momento dell’espressione, il momento della creazione e lo spazio comune che la musica rivela.>> (Dan Ruccia).
Dopo la perfetta recensione di Dan Ruccia della quale abbiamo appena citato un frammento, uscita nel 2012 su Dusted al momento della prima ristampa in digitale di “Organic Music Society” doppio LP di Don Cherry uscito originariamente nel 1972 ed introvabile da anni, potrebbe non esserci più alcunché da scrivere e aggiungere.
Ma non possiamo né vogliamo sottrarci alla sfida con cui questo pezzo di ubiquità stilistica musicale, figlio della creatività dell’unico vero griot planetario, continua ad incalzare chi ha orecchie, testa e cuore per entrare in simbiosi con questi suoni. Anche perché “Organic Music Society” potrebbe essere, fin dal titolo, il disco manifesto della filosofia di Taribari per come è nata e, soprattutto, per come si è evoluta negli ultimi anni.
Certo il termine “organic” aveva un significato e sfumature di senso diverse quando Don Cherry lo usò oltre 40 anni fa, rispetto a ciò che – sostanzialmente e prevalentemente – significa oggi ovvero biologico, naturale, non contaminato. Eppure, anche nel senso in cui lo intendeva Don Cherry, sono più le similitudini che le differenze con ciò che vuol dire per noi: che viene dalla terra, dal popolo, dalle sue viscere, dai suoi cuori, dai suoi organi. Non inquinato, non filtrato né assoggettato alle regole del mercato.
Don Cherry era un geniale musicista, trombettista e polistrumentista, di fondamentale estrazione jazz seppur di quello più innovativo, eretico e rivoluzionario. Partner musicale di Coltrane, Sonny Rollins, Paul Bley, Charlie Haden e Archie Shepp, fu soprattutto coprotagonista dello storico quartetto di Ornette Coleman e cioè di una delle 10 cose più importanti accadute alla musica del XX secolo.
Ovviamente, al momento della sua uscita ed anche molto dopo, “Organic Music Society” fece storcere il naso ai jazzofili – gentaglia della stessa risma di quella che definì rumore il sound del primo tour nella west coast di Charlie Parker e Dizzy Gillespie o che sostenne (e, ahimè, sostiene) che il Miles elettrico dei primi 70’s facesse merda commerciale senza senso (sigh!) – e scatenò l’odio viscerale dei critici jazz che mai si erano ripresi dall’oltraggio di vederlo suonare una cornetta pakistana ultra cheap accompagnando Ornette ed il suo sax di plastica nella rivoluzione che cambiò per sempre la musica afroamericana e la musica improvvisata in generale.
Come potevano apprezzare, costoro, i vari ensembles sempre diversi che suonavano nel disco, più simili ad una comune radicalmente democratica che ad un gruppo musicale? Come potevano godere di quella pulsione desiderante nella quale la situazione, le circostanze, il contesto, l’atmosfera dell’evento erano quasi altrettanto importanti che la musica stessa? Come potevano sintonizzarsi – poveri topolini ciechi dell’accademia jazz – con suoni e voci che, più che brani musicali, erano punti d’incontro di forze ancestrali, meditazione sullo spirito della creatività, stare insieme e fare con la musica qualcosa che abbia un senso e significhi qualcosa? Come potevano capire che, come Don Cherry non si stancava di ricordare con le opere più che con le parole, che il jazz altro non è che musica folk?
Musica e suoni che vengono dall’Africa, dal nord e dal sud America, dall’Europa del nord, dall’India, dal Tibet e dalla Cina. Tenendosi ovviamente ben lontano, forse perché era il 1972, dai party tartine e olivette della world music che hanno funestato i decenni successivi.
Ma cosa c’è, dunque, dentro “Organic Music Society”?
Solo due dei 12 brani sono stati registrati in un vero e proprio studio di incisione. Il resto live in differenti siti in Svezia e in Danimarca: dalla cupola geodesica davanti al museo di arte moderna di Stoccolma alla scuola di musica classica per giovanissimi dove Don Cherry era stato chiamato a tenere alcune lezioni, alle registrazioni domestiche con la moglie Moki, il batterista turco Okay Temiz e altri musicisti scandinavi e di altre disparate provenienze. Musicisti che appaiono e scompaiono a seconda di dove Cherry decideva di registrare in quel particolare giorno, in quel particolare momento. L’unica costante è lui, Don Cherry e la sua visione mistica, il suo ruolo di medium, di infantile giocoso Elegguà, di shamano sorridente che catalizza e veicola la musica del pianeta.
“North Brasilian Ceremonial Hymn” è la registrazione, fatta alle sei del mattino a Copenhagen, di voci, berimbao – suonato da un allora sconosciuto vagabondo musicale di nome Nana Vasconcelos – e piccole percussioni: una via di mezzo tra un mantra buddista, un canto rituale del candomblè e un lamento delta blues.
Tra una cover di Dollar Brand, una di Terry Riley e una di Pharoah Sanders i due brani centrali del disco: “Relativity Suite” in due movimenti e “Home”. Nel primo su una linea ripetitiva di basso doppiata da quella mantrica del doson ‘ngoni adagiata su un tappeto di infinite e ipnotiche percussioni, si dispiega la voce di Cherry e il suo canto panreligioso che spiega e riassume il senso filosofico dell’opera. Il secondo, “Hope”, si apre col piano suonato da Cherry che dispiega una melodia dolce e celestiale adagiata sulla batteria di Temiz che fa uno splendido lavoro sui piatti mentre il canto quasi sempre senza parole dello stesso Cherry e di un coro degli altri musicisti si attorciglia ai flauti di Tommy Goldman e Tommy Koverhult e alla meravigliosa tromba di Maffy Falay: 10 minuti di pura magia, di viaggio mistico in un altroquando. Impagabili poi la versione di “Terry’s Tune” di Terry Riley con Cherry alla tromba e al piano e Okay Temiz alla batteria, entrambi in piena botta free, accompagnati da un’orchestra di archi suonati dai giovanissimi alunni, abituati a suonare solo musica classica, del music camp dove Cherry era stato chiamato a spiegare il suo metodo compositivo. Così come il gran finale di “Resa” con Cherry all’ harmonium, Moki alla tambura, Bengt Berger alle tablas ed il coro degli insegnanti della scuola elementare che si cimentano in un canto-preghiera indiano.
Se dovessi giudicare questi brani da un punto di vista strettamente musicale, giudicarne tecnicamente e formalmente i contenuti vestendo i panni del musicologo potrei avanzare dubbi sulla visione musicale complessiva del progetto, potrei dirmi non pienamente convinto della loro struttura. Ma, come dice Dan Ruccia, <<la loro esistenza come musica è quasi completamente incidentale ed arbitraria. Sono, fondamentalmente, rituali e socialità riutilizzata>>.
Ma nonostante ciò, anzi forse proprio per questo, ogni volta che le ascolto o che mi riecheggiano nella testa, ogni volta che inaspettatamente mi suonano nel cervello e nella memoria, non posso fare a meno di perdermi completamente e meravigliosamente nella maggior parte di queste incisioni. E questo in fondo, il perdersi in questa magia and to flow with time, è tutto ciò che conta.
Facile ed istintivo per me l’abbinamento. Con un vino che, quando ne ricordo profumi e sapori, nella mia mente fa suonare il disco di Don Cherry così come quando ascolto “Hope”, incontrollata cresce in me la voglia di andare su internet ed ordinarne una pedana (anche se spesso è introvabile anche una sola bottiglia) tanto i due – disco e vino – si richiamo a vicenda.
Si tratta di un vino bianco da uve Chenin blanc: Les Gains de Maligné 2009 prodotto sotto la denominazione Anjou nella Valle della Loira da Cyril Le Moing, vigneron a Fline.
Niente chimica di sintesi, nè diserbanti né concimi chimici nei circa due ettari e mezzo di vigna di più di 35 anni di età (che arriva fino ai 50 anni per certi ceppi) adagiata su un terreno di quarzi e calcare da conchiglie fossili. Niente interventi che non siano quelli della natura in cantina dove, dopo la malolattica in barriques e l’affinamento, il vino viene imbottigliato a mano senza filtrazioni.
Questo 2009 lo assaggiai insieme a Gio, mia moglie, nel 2013 accompagnando una cena sontuosa e indimenticabile al ristorante dello Château Richeux di quel genio assoluto della cucina con le spezie che risponde al nome di Olivier Roellinger. I quattro anni dalla vendemmia avevano reso perfetto, seppur ancora in forma e salute smagliante tanto da far presagire ancora lunghi anni di meraviglia, questo vino naturale dalla mineralità straripante, complesso e sensuale come pochi ne ho assaggiati, col gusto e l’olfatto, nella mia vita tanto da diventare protagonista della cena nonostante a prepararla ci fosse uno dei grandi geni della cucina contemporanea.
L’abbinamento con la cucina sincretica di Roellinger, capace di sposare con essenziale leggerezza e semplicità i sapori di più continenti (con predilezione per l’India ed il sud est asiatico) in un solo piatto, rende perfetto, riecheggiandolo, quello con il sincretismo musicale di “Organic Music Society” del quale condivide appieno la filosofia che esponevamo in apertura di articolo: che viene dalla terra, dal popolo, dalle sue viscere, dai suoi cuori, dai suoi organi. Non inquinato, non filtrato né assoggettato alle regole del mercato. Peace & love.
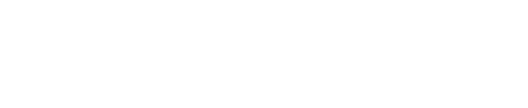
Commenti recenti